Estratto: Pellegrino di cemento
Pellegrino di cemento
Le Voyage d’Orient a 100 anni da Le Corbusier
di Flavio Stroppini
Indice
Nota dell’autore
Prologo: Alpe Geira
Parte prima: Il lasciare
Ligornetto – 2. La-Chaux-de-Fonds – 3. Tübingen – 4. Stoccarda
Halle – 6. Dessau – 7. Wittenberg – 8. Berlino
Parte seconda: L’incamminarsi
Dresda – 10. Praga – 11. Vienna – 12. Bratislava
Esztergom – 14. Danubio – 15. Budapest
Baja – 17. Belgrado
Parte terza: Il perdersi
Negotin – 19. Craiova – 20. Bucarest – 21. Veliko Tarnovo
Kazanlak – 23. Edirne – 24. Istanbul
Bursa – 26. Uludag
Parte quarta: Il cercarsi
Alessandropoli – 28. Salonicco – 29. Ouranopoli – 30. Monte Athos
Viaggiare – 32. Atene – 33. Patrasso – 34. In mare
Parte quinta: Il tornare
L’Italia
Epilogo: Alpe Geira
Ringraziamenti
Note
Agli autisti,
che sempre e in qualsiasi modo
mi hanno trasportato da un punto all’altro.
Nota dell’autore
Nel 1911 un giovane architetto svizzero viaggia nei Paesi dell’est. L’uomo diventerà un’icona dell’architettura moderna: Le Corbusier.
Il viaggio è parte dell’epica della storia dell’architettura: le Voyage d’Orient.
Sono passati 100 anni. Cosa sono quei luoghi?
Me lo sono domandato una notte d’inverno, sfogliando i Cahiers de voyage di Le Corbusier. Linee, parole, qualche frase, misure, cifre e nomi di città conosciute e sconosciute.
Dovevo ripercorrere le sue tracce.
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Svizzera di Radio e Cultura (FSRC), è stato quello di raccontare il viaggio. Ogni giorno una puntata (registrata e montata) alla Radio della Svizzera Italiana ReteDue. Ogni settimana su un quotidiano della Svizzera italiana (LaRegioneTicino). Il sito http://www.voyagedorient.ch, al centro della piattaforma narrativa. Alla fine del viaggio la scrittura di un libro e di un radiodramma.
Sono partito con uno zaino e una tracolla, senza troppo pianificare – nessun albergo, nessun aeroplano – convinto che l’aver letto molti romanzi d’avventura sarebbe bastato. Non è andata così.
È stato questo il regalo. Perdere sicurezze, cercarne altre.
Undici settimane (estate 2011) seguendo una guida di cent’anni fa. Scoprendo Le Corbusier. Perdendomi e ritrovandomi. Scoprendo l’uomo e la sua possibilità di fratellanza.
Passeggiando per il nostro giardino di casa, così vicino e così lontano.
Questo è il racconto.
Ligornetto, novembre 2011
Ogni tanto giura di cominciare una vita migliore.
Ma come viene la notte con i suoi consigli
con i suoi mezzucci e le sue malie,
ma come viene d’impeto la notte, allora
al corpo che esige e reclama, a quella
stessa fatale gioia, egli smarrito, fa ritorno.
Kostantinos Kavafis
Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi.
Il re pallido, David Foster Wallace
Prologo: Alpe Geira
Una settantina di vacche risalgono lentamente la piccola valle. Due cani lavorano ai fianchi della mandria, mentre il pastore, dal centro, controlla che nessun animale rimanga indietro.
Luna crescente e le prime stelle in cielo: la notte cala. Cammino a qualche decina di metri dal pastore, osservandone i movimenti. Metro dopo metro le vacche si riuniscono, indirizzandosi al pascolo vicino all’alpe. Il suono dei campanacci si trasforma in coro e chiudendo gli occhi sembra il suono liquido di un’onda o di un fiume che cerca il mare. Mi siedo e vedo la montagna, con tre ruscelli che lacrimano sulle rocce e della neve: macchia bianca nel primo buio. Questa è casa mia! penso. Come una marea i ricordi di viaggio. Luoghi, volti, aromi, sensazioni. Disordinati s’accatastano tra i pensieri, veloci. Bisognerà fare ordine, archiviare, definire. Perché ormai è la quotidianità che m’attende. Dopo undici settimane di viaggio ho scoperto che il mondo non è zaino e tracolla, ma spazi e oggetti. Non potrò fuggire ancora per molto. Ma questa sera, in questa valle materna, voglio abbandonarmi al ricordo, seguendone il ritmo e il colore, come fosse un quadro ancora da dipingere. Come fossi uno di Quelli, che un giorno tornano al paese / a guardare le piante dopo la pioggia / odorare il fieno, incrociare le gambe / sul sedile di pietra; (…).
È passata una stagione all’alpe. Sono passati cento anni. Tu non ci sei più e forse non ci sei mai stata. L’odore del caffè sale fino allo studio, al terzo piano. Fuori la vite si è arrampicata, mescolandosi all’edera, coprendo le finestre. Passare i corridoi è come essere in un giardino-labirinto. Avanti e indietro, sul cotto liso dagli anni. Ci sono oggetti che ricordano storie, i pochi che ho tenuto, che sembrano troppi. Un’altra voce mi chiama, non è la tua. È ora di scendere, di tornare a vivere. Sono serviti tre mesi? È servito viaggiare?
No, senza zucchero il caffè! Grazie.
C’è da ricostruire una quotidianità e raccontare un storia. Le Voyage d’Orient 100 anni dopo Le Corbusier.
Parte prima
Il lasciare
- Ligornetto
Non manca molto alla partenza. Il tavolo da lavoro è ricolmo di dettagli. I giorni sono dedicati all’analizzare il progetto da diversi punti di vista. E un metodo per evitare problemi pratici.
Il tempo in viaggio cambia ritmo. Accelera e rallenta, appena fuori dalla quotidianità. Il domani non ha più molto senso. L’importanza è sull’oggi. Viaggiare significa mettere in relazione i nostri luoghi con quelli degli altri, intuirne le similitudini, affascinarsi alle differenze, scoprirsi uguali. Se passiamo la vita a inseguirci, in viaggio ci siamo abbastanza vicini.
Ho scelto di percorrere questo tragitto solo. Con mezzi pubblici. Restando a terra, toccando la terra. Ascoltando e guardando.
Cerco i dettagli che affascinarono Le Corbusier. Cerco storie da raccontare. Ora devo partire. Voglio, con dolcezza e speranza, camminare.
È accaduto che sei sparita, da un giorno all’altro. Non sono servite le rose e le parole. Nemmeno un camino d’inverno e molta legna da ardere. Partire da solo sarebbe stato un problema, ora è espiazione. Penso ad un madrigale di Dowland. “Flow my tears, fall from your springs! / Exiled for ever, let me mourn; / where night’s black bird her sad infamy sings, / there let me live forlorn”. Era il XVI secolo. Tutto quanto già raccontato, già vissuto. Per questo, ogni ora che s’avvicina alla partenza, aumenta la curiosità. Cos’è l’uomo? Dov’è? Cos’è la fratellanza? Dov’è la magnificenza?
I pensieri sono interrotti da amici nella cucina di casa. Abbracci, poche parole, battute sarcastiche. “Torna però” dice Zeno.
Scrivo prima di addormentarmi, dopo aver vagabondato per casa e guardato le stelle. Non ho pensieri. solo qualche domanda dall’impossibile risposta.
Non ho ancora deciso che scarpe calzare.
-
La-Chaux-de-Fonds
Partire. Da più di un mese lo immaginavo. Agli amici ho sempre detto di sognare quell’attimo in cui avrei passato le Alpi. Là, abbandonando la mia lingua, sarebbe iniziato il viaggio. Da quel punto, dentro al tunnel del San Gottardo, sarebbe poi stata tutta discesa. Non mi sarei più ritrovato in nessun luogo così alto. Mi aspettano le grandi pianure del nord, poi quelle dell’est ed il mare. Gli Appennini, quando risalirò l’Italia, ma sarà già un tornare a casa.
Dov’è la mia casa? Per qualche mese saranno le stanze degli alberghi, le carrozze dei treni, le stazioni, i racconti della gente. Una volta ho letto che esiste una linea oltre la quale la gente non ti saluta più dalla banchina alla carrozza del treno. Ho letto che la linea in Svizzera si situa tra Lucerna e il lago di Ginevra.
Sono passato da Arth Goldau. Direzione La Chaux-de-Fonds, dove Le Corbusier è cresciuto. È un buon inizio partire dal suo luogo di nascita. Un grande architetto mi ha detto che in fin dei conti noi semplicemente nasciamo, viviamo e moriamo.
Il partire è malinconia. Ma chilometro dopo chilometro cresce la curiosità. Cancella tutto. La Svizzera Centrale, come una benedizione di pascoli e frutteti, scorre là fuori. Mi riempie. A Biel, o Bienne bevo una birra e fumo una sigaretta. Poi risalgo sul treno. Una bambina, credo turca, abbracciata alla madre vestita di rosa e giallo, mi fissa e con la mano fa un rapido cenno di saluto. Sorrido e rispondo. Infine è la notte che mi accoglie leggera, trasportandomi al paese natale di Charles-Edouard Jeanneret-Gris: Le Corbusier.
Ho risalito via Modulor, arrampicandomi sulla collina che sovrasta La Chaux-de-Fond. Ho abbandonato le strada principale, Avenue Leopold Robert, con il suo filare centrale di alberi. Ho lasciato il vecchio centro, la piazza del mercato, i minuscoli bistrot, le vetrine delle orologerie. Sono salito verso le prime ville costruite da Le Corbusier, nel giardino della sua città. La Maison Blanche se ne sta placida, beata, sicura, al confine del bosco. Aspetta il mio sudore. Mi asciugo fumando una sigaretta.
Una donna sulla quarantina con la faccia triste e dei volantini in mano si avvicina e chiede se ho visto il suo cane, un pastore tedesco dal nome Bunny. Mi è sembrato strano il nome per un cane, Bunny. Ma forse è un soprannome che è diventato un nome. Come Charles-Edouard Jeanneret diventato Le Corbusier. Rispondo No! alla donna che mi porge un volantino con la fotografia del cane e un numero di telefono. Poi si allontana. Un ragazzo si avvicina. Parla inglese, con accento spagnolo. Anche tu architetto? chiede. Viene da Barcellona, è uno studente. Vuole vedere la città natia di Le Corbusier. Chiede se andiamo a mangiare qualcosa, rispondo che non ho tempo. Devo restare qua ancora un poco. Lui sorride e sembra capire. Si allontana verso la strada degli elettricisti, con le fabbriche di orologi sullo sfondo, dall’altra parte della valle.
Ridiscendo incrociando qualche bicicletta e dei saluti. Vista dall’alto La Chaux-de-fonds sembra una città in dubbio sull’altezza: da una parte i vecchi palazzi bassi e dall’altra, in rapporto simmetrico, delle torri. Ma non sono storie che m’interessano.
Rue de La Serre, numero 38. Il 6 ottobre 1887 vi nacque Le Corbusier. È una via anonima con palazzi antichi e nuovi mescolati casualmente. Il numero 38 è una facciata altrettanto anonima: al pianterreno c’è un negozio di giocattoli e di noleggio costumi per carnevale. Sulle vetrine una patina di polvere, dentro dei grossi cuori formati da palloncini rossi e bianchi. Siedo sui quattro piccoli scalini dell’entrata. Gli stessi che il piccolo Jeanneret saliva e scendeva nella sua infanzia. La sua famiglia emigrò dopo l’editto di Nantes, che cacciò i protestanti dalla Francia. Per quello l’industria orologiera arrivò in Svizzera: migranti. Scatto qualche fotografia. C’è una targa commemorativa: In questa casa il 6 ottobre 1887 nacque Le Corbusier. Sotto però qualcuno, con un pennarello ha scritto Lait ce Beton! Latte questo cemento. Scoppio a ridere. Il cemento come la vera madre di Le Corbusier. Latte. Seno materno la struttura della casa.
Si avvicina un bambino. Perché scatti fotografie? Chiede. Gli rispondo che in questa casa è nato un personaggio famoso. Un calciatore? chiede. No! Un architetto! rispondo E cosa fa un architetto? chiede. Costruisce le case rispondo. Ah! dice Come quelli dell’impresa Forberes, che stanno rifacendo la casa dei vicini. Poi se ne va, annoiato.
Osservo l’ingresso della casa. Eccoci caro Le Corbusier, ora inizia il viaggio. Partiamo dallo stesso punto. Per la prima volta mi accorgo che questa storia è qualcos’altro. Forse il mio viaggio finisce qua, con il suo inizio. Adesso parte la vita.
Andando in stazione, dove mi attende il treno per Zurigo da dove proseguirò per la Foresta Nera, incontro Juan. Mangia un kebab, mi invita a unirmi. Mangio. Buono. Lui afferma che a Istanbul sarà tutta un’altra cosa.
In treno il vento nei pascoli fa delle erbe alte un mare.
Sono partito che c’era il sole. Vincenzo, accompagnandomi in stazione, mi ha abbracciato velocemente, come a dirmi “Parti, cosa te ne importa? vai!” Vincenzo custodisce le chiavi della casa, invierà soldi tramite Western Union se ci saranno problemi, bagnerà le piante di cui non mi importa molto. Ma se a uno non importa delle piante che razza di persona è? Mi piace vederle in natura, costrette in un vaso m’infastidiscono. Limitiamo il mondo. Costruiamo e cerchiamo di addomesticare la natura, gli altri e noi stessi. Si nasce, si vive e si muore, così diceva l’architetto. Abbiamo costruito il mondo. Dev’essere che abbiamo bisogno di fisicità. Perché poi non ci basta semplicemente vivere. Abbiamo bisogno di certificare la nostra esistenza. E lo facciamo cercando qualcuno che ci ricordi. Talvolta funziona.
Più passano gli anni più Vincenzo racconta storie che servono. Forse le ha sempre narrate, ma inizio ad intuirle ora. Forse dopo questo viaggio ne capirò di più. Che poi l’ho idealizzato, il viaggio. Come fossi un qualsiasi romantico ottocentesco. Infatti passando le Alpi m’immagino il ritorno e solo dopo avere cambiato il primo treno, a Lucerna, mi accorgo d’essere partito.
-
Tübingen
La Foresta Nera è un mare. Un mare solido nel quale è impossibile annegare. Però se la attraversi in un giorno di vento la vedi che si muove, onda dopo onda. Nel mezzo isole. Paesi aggrappati alle rocce, solitamente dominati da una chiesa, un castello o una cattedrale.
Sono arrivato a Sciaffusa di prima mattina. Zurigo l’ho vista all’alba, quindici minuti e un gipfel con caffè da un ambulante. Mi sono fermato a Sciaffusa perché volevo toccare la Svizzera con i piedi prima di lasciarla. Proseguo verso Singen, Engen, Tutlingen, navigando nel mare della Foresta Nera. Ralf, che tornava a casa, dopo la Pentecoste passata con i parenti sul lago di Costanza, mi ha raccontato che la chiamano così, Nera, perché è talmente fitta che la luce non raggiunge terra.
Cambio treno e approdo alla mia isola. Una cittadina arroccata su di una collina: Tübingen. Ci arrivo nell’ora in cui gli studenti escono dalle università e sciamano tra le stradine moltiplicandosi in mille voci senza volto.
Ho deciso di fermarmi a Tübingen per due motivi. Primo: una delle più vecchie biblioteche d’Europa, la biblioteca del silenzio. Secondo: la torre nella quale era stato rinchiuso il poeta Hölderlin. La torre sta accanto al fiume Neckar. Pietre su pietre. In un ristorante italiano maccheroni al pesto. Poco più in alto un gatto osserva i passanti e le barche sul Neckar.
Barche come specie di gondole sul fiume, ma con un’eleganza più austera. Lunghe tre metri e sedute sulle panche ai lati posto per una dozzina di persone. A poppa un giovane con una lunga pertica, che immerge nell’acqua fino al fondo del fiume dove spinge la barca. Scendo al piccolo porticciolo, uno spiazzo ghiaioso, e parlo con Hans. Racconta che sono tutti studenti i “portatori” delle barche. È un obbligo delle confraternite “fare turni al fiume”. Mi spiega che sotto il ponte principale c’è una corrente bastarda, che un vero “portatore” di barche deve riuscire a fare due giri attorno al pilone centrale del ponte, altrimenti non è nessuno. Me lo vuole dimostrare. Andiamo sull’acqua a girare attorno al pilone, con il gatto ed il fantasma di Hölderlin che ci guardano dall’alto.
Oggi mi diverto, mi rilasso. Partire ha già cambiato la percezione del tempo e le azioni assumono importanze diverse. Devo allenare lo sguardo. Solo allenato potrò cercare il mondo di Le Corbusier.
Sbarco e saluto Hans. Voglio vedere la Biblioteca del Silenzio. Lui propone Conosco un posto dove c’è buona birra. Non rispondo, allora aggiunge Non c’è molto silenzio ma trovi persone che sono come libri. Poi ride. Cerco una camera e ti raggiungo dico. Risponde che alla camera ci si pensa dopo. Una soluzione la si trova sempre. Basta cercarla al momento giusto. Lo seguo. D’altronde se uno finisce su di un’isola il minimo che debba fare è adeguarsi alla cultura del luogo.
La Svizzera finisce presto, a Sciaffusa, con l’acqua che precipita nelle cascate del Reno e una bandiera rossocrociata. Non sono nazionalista. La fabbrica dei dadi Knorr e quella degli Arbre Magique catalizzano la mia attenzione. Chissà perché al posto di pensare all’architettura penso a Smell like Teen Spirit dei Nirvana. Forse per gli Arbre Magique, visto che Teen Spirits era la marca di un deodorante a basso costo venduto a Seattle. Ma penso per non pensare.
È finita con della birra chiacchierando di Bach, fin quasi al mattino. Così per essere certo d’essere stanco, appena partito.
-
Stoccarda
Arrivare a Stoccarda significa girarci attorno. La città è incastonata in un naturale alloggiamento nel fondo di una valle. Le colline attorno la assediano. Arrivarci la notte significa addentrarsi nelle luci, sempre più fitte, sempre più invadenti.
In stazione mi aspetta un amico, Joachim. Sarà la mia guida nei prossimi giorni. Abita a Bad Canstatt, a pochi chilometri dal centro distrutto durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito. Bad Canstatt prende il nome dai diversi bagni presenti un tempo. Qualcuno resiste, qualcuno chiude. Piove. Ci si bagna anche qua fuori. Non sembra una città: tipiche casette con il tetto spiovente. Come uno stereotipo. Tutto è verde attorno al fiume Neckar. Mangiamo Maultaschen e insalata di patate, beviamo qualche birra. Ci scambiamo le esperienze degli ultimi mesi e riempiamo le storie con molti silenzi.
Mi sono svegliato che il sole entrava dalla finestra passando accanto alla torre della Daimler Benz. Beviamo del caffè con il sole sul terrazzo. Parliamo di quello che ieri era silenzio. È tutto semplice. Dovevamo farlo da tempo. Andiamo in un Bier Garten sulla collina ricolma di vigneti. Qualche birra. Poi sulla torre televisiva che domina la città. Da lassù la geografia è chiara. Su di una mappa a 360 gradi i luoghi che visiterò nei prossimi mesi e le distanze che mi separano da essi. Infine, dopo essere scesi per una valle con un treno a cremagliera, risaliamo una delle piccole collinette del centro città. In mezzo ad un parco osserviamo il nuovo e il moderno mescolarsi senza troppo scontrarsi. “Architettura pragmatica” la chiamiamo. Del centro vedo poco, Königstrasse e il castello. Torno al terrazzo di Joachim, dal quale si domina la città attorniati dalla periferia. Ci raggiunge la sua compagna, Anne, con un vino rosé della zona. Me ne sto sempre in alto, come se per mappare questa città uno debba rimanere fuori dal centro e salire sulle colline o sulle costruzioni dell’uomo e guardarla da lontano.
Che dire di questo giorno? Mi piace il rumore delle automobili di Stoccarda. Da lontano ho visto anche un pappagallo. Sono fuggiti dallo zoo. Tornano ogni anno, come se avessero bisogno della vicinanza della prigione per sentirsi vivi, per certificare un’identità. Come noi uomini. Uomini come pappagalli.
Con Joachim discutiamo di gerani e vite canadese. Starebbe bene sul loro terrazzo. La notte guardo le luci della città. Ci sono molte gru. Forse un mondo da costruire.
Parliamo, ognuno perso nei suoi pensieri, nel suo accumulare ricordi da smaltire e ordinare con il sonno. Anne ha preparato un letto in salotto, vicino a una lampada a palla sul pavimento in parquet chiaro. Joachim mi ha portato una bottiglia d’acqua. Ci salutiamo come fossimo vicini da un mese. Il silenzio è tutto quanto ci volevamo dire, perché negli occhi, negli sguardi, in un abbraccio, c’era quel che serviva. Tutta fisicità. Tutto il bisogno di essere ricordati, tutto il senso del vivere. Talvolta funziona.
Da qualche parte Vincenzo ascolta musica jazz. Forse pensa che il mondo è un fottuto cane che si morde la coda, come il tempo in una poesia beat. Apro il frigorifero e prendo una lattina di birra. Esco nella terrazza al quinto piano e accendo un’altra sigaretta. Il viaggio è iniziato e non è successo niente. Quindi è successo tutto.
È di nuovo sera. Qualcuno nel palazzo di fronte suona un sax. Ricevo antidolorifici alla codeina, antibiotici, Imodium e qualcosa contro il vomito. Qua conoscono cosa non penso e risolvono il problema dell’eventuale stare male fisico. Finisco la serata sul terrazzo. Un kirsch bavarese e una sigaretta.
Con Joachim andiamo al centro della Foresta Nera. Il viaggio con la sua jeep ci regala un cielo drammatico. Vasto, pieno di luminescenze che si scontrano con le nuvole e temporali tutt’attorno. Talvolta sole. È come intravedere l’esterno della cucina dei mangiatori di patate di Van Gogh. Chissà perché? Oggi è meglio che non mi faccia troppe domande. Sono passato spesso da questi luoghi e mi accorgo che rimuoverli non serve a niente. La loro bellezza è fredda e cruda. Piena di contrasti. Qua è bianco o nero. Come la donna che ho amato. Abitava qua. Talvolta la vita prende una direzione diversa, come nelle stazioni: su un binario a fianco del tuo c’è un treno e per un poco, se parti assieme, fai lo stesso viaggio ma poi lo vedi allontanarsi e immagini il suo percorso. Per qualche tempo riesci, poi rinunci e ti concentri sul tuo presente.
Torniamo e a una stazione di benzina chiedo a Joachim di darmi il tempo per due sigarette. Alzo lo sguardo, c’è del vento e le nuvole battagliano l’una con l’altra. Regalano una breccia di cielo. Esce tutto il peso, come vomito sui campi. Esce tutto come dopo un violento pugno alla bocca dello stomaco. Svanisco. E dura un attimo. Meno di un secondo. Joachim finisce di pompare benzina nel serbatoio della jeep. Forse non si è accorto di nulla. Oppure finge bene, come fanno gli amici veri quando sanno che non c’è nient’altro che essere presenti per aiutare. A volte le parole non servono. Chiusa la breccia nel cielo accendo la seconda sigaretta con la brace della prima. Sono leggero. Ecco, il viaggio parte ora.
Anne racconta di suo padre: ha costruito un molo in Polonia. “È una grande persona chi costruisce un molo” le dico. Dovrò farlo anche io un giorno. Non sei un uomo se non hai costruito un molo.
continua…
Link: Pellegrino di cemento


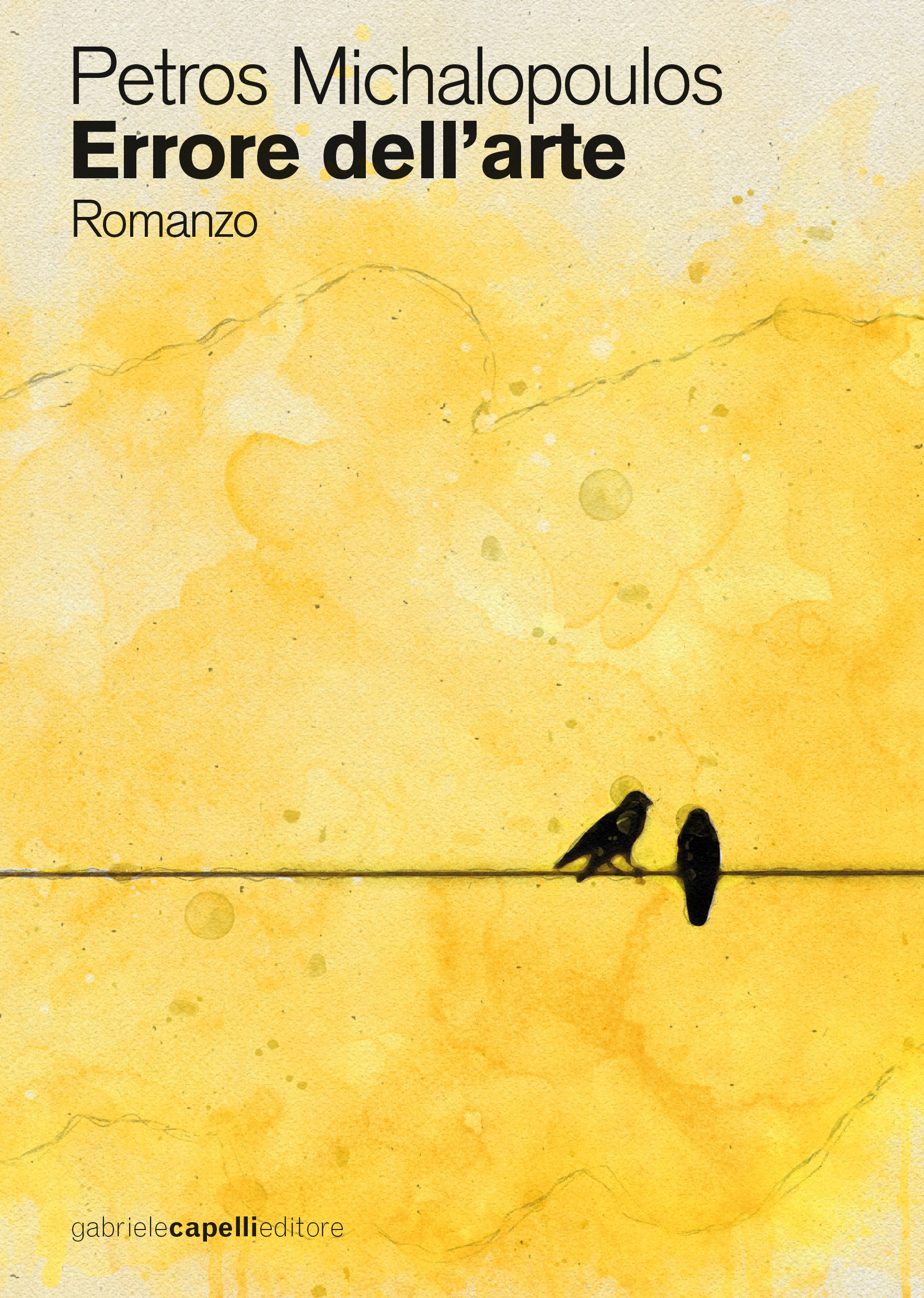

1 thoughts on “Estratto: Pellegrino di cemento”