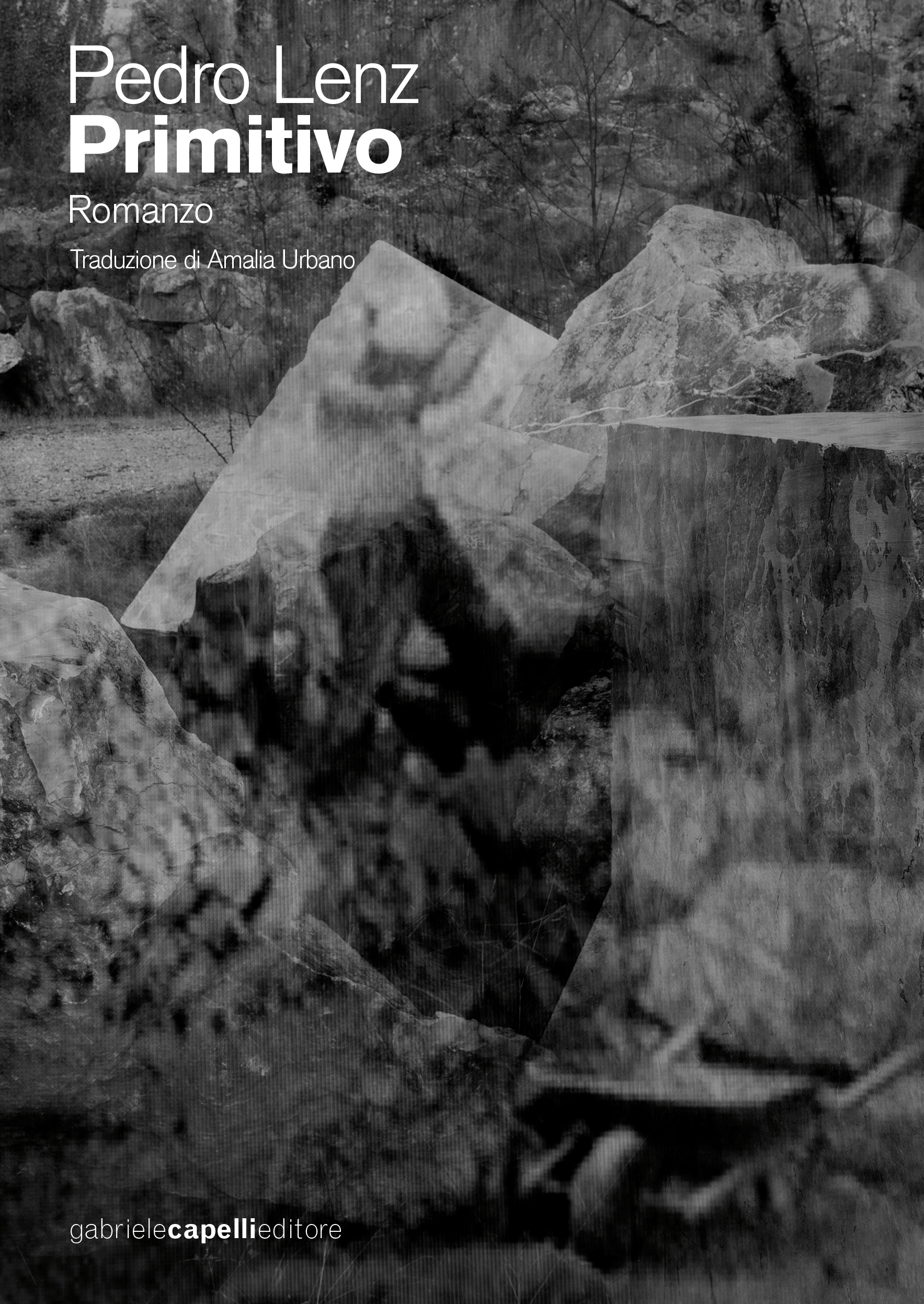«Questo è un romanzo bellissimo» – Corriere del Ticino

© Corriere del Ticino, 02.03.2021
Se l’innocenza non basta
Il nuovo struggente libro di Begoña Feijoo Fariña trascina il lettore nella devastante esperienza vissuta da una donna vittima delle “misure coercitive a scopo assistenziale” che pesano sulla coscienza svizzera del Novecento.
di Luca Orsenigo
Questo è un romanzo bellissimo. Si potrebbe dire un romanzo che unisce il vero, l’utile e l’interessante se con ciò, per quanto in realtà sia proprio così, non ci si nascondesse dietro una scontata formula manzoniana.
E allora diciamo ancor più semplicemente che ascoltare una storia – e che razza di storia, questa – è la maniera più intelligente per capire se stessi e il mondo che ci circonda: saper ascoltare è la conditio sine qua non di ogni dialogo sincero e profondo, sia che si tratti di prestare orecchio all’interior intimo nostro, sia che si dia spazio alla voce dell’altro da noi.
E qui, in questo Per una fetta di mela secca, l’arte di Begoña Fariña non solo ascolta e non imita la vita, ma la interroga e si fa narrazione di lei. L’una si nutre dell’altra e la storia, vera, verissima, più che verosimile, riassume in una sola vicenda le tante uguali che ancora bruciano sulla pelle di molti e condannano coloro che le hanno permesse.
Siamo infatti dalle parti del non sapevo e del non credevo, il che, dopo gli orrori del secolo breve, non si può neppure pensare senza farsi complici di quelle nefandezze. Alla fine del romanzo viene infatti da domandarsi quale mente perversa, quale lucida pedagogia alla Pol Pot abbia partorito un simile piano di «misure coercitive a scopo assistenziale» per i bambini della Confederazione, coniando tra l’altro un ossimoro che dovrebbe scuotere la coscienza al solo pronunciarlo. Del resto, la vicenda di Lidia Scettrini, tra spersonalizzazione e malnutrizione, sterilizzazioni e abusi sessuali, carnefici e indifferenti, ricorda altre e ancor più tragiche vicende della Storia.
Una sorta di voragine che tutto inghiotte. La voragine dell’abitudine a distogliere lo sguardo e la voragine del giudizio perbenista. «Le ingiustizie sono ovunque nel mondo, le compie anche chi crede di volerci fare del bene. O forse è solo una maschera dietro cui si nascondono. Portare via una figlia a una madre perché il mucchio della legna non è abbastanza alto da resistere fino alla fine dell’inverno? Portargliela via perché i suoi vestiti non sono abbastanza puliti? O solo perché la bambina giorni prima ha rubato una fetta di mela secca? No, non è per questo che l’hanno fatto. L’hanno fatto solo perché qualcuno ha potuto farlo e nessuno si è opposto. Perché a qualcuno non piaceva che mamma fosse divorziata, povera e ribelle». Gli avvenimenti sono facili da riassumere nella loro logica malvagia e persecutoria.
Terra di nessuno
Lidia vive a Cavaione, un villaggio della Valposchiavo, nei pressi di Brusio. E già questo – sia detto per inciso – è segnale di diversità, trattandosi di una comunità che ancora dopo la metà del XIX secolo non era né italiana né svizzera. Il padre poi abbandona la moglie e si trasferisce altrove, lasciando Lidia e sua madre povere e preda delle maldicenze. Due donne sole e per di più povere, qualche peccato devono averlo ben commesso, no? Se poi come avviene a causa dei continui sberleffi dei compagni, Lidia ruba una fetta di mela secca ad un altro bambino, il teorema ha una sua definitiva dimostrazione: la madre incapace di educare, la figlia abbandonata a se stessa, preda degli istinti più aberranti.
Da qui inizia il calvario delle misure di assistenza, coercitive of course. Prima in un istituto diretto da suore non meglio identificate, presso le quali sembra di assistere alla pantomima inscenata nei campi di concentramento a favore degli ispettori della Croce Rossa e qui invece a beneficio degli ispettori governativi che dovrebbero vigilare sulla correttezza e l’utilità di quelle misure decise arbitrariamente. È per loro infatti che le sorelle allestiscono un castello di falsità, mentre magari Lidia e compagne sono castigate, per un sì o per un no, a trascorrere notti nel porcile dell’istituto. Poi, all’età di quattordici anni, Lidia è assegnata all’amorevole educazione di una famiglia contadina presso la quale viene ripetutamente abusata e trattata come nemmeno un cane alla catena, letteralmente, salvo poi doversi occupare della moglie del proprietario gravemente ammalata, unico momento di quella cupa vita di internata, in cui fa capolino un briciolo di umanità. E infine certo, con la maggiore età, arriva anche la libertà. E con questa il ritorno a Cavaione. La scoperta della morte della mamma, mai incontrata in tutto l’arco della rieducazione forzata. La conoscenza della compagna del padre, anch’egli ormai morto, al quale era stato impedito di rivedere l’unica figlia. La faticosa ricostruzione di una vita sulle le macerie della buona educazione. E finalmente un amore. Un amore adulto e rispettoso, gratuito e inaspettato.
Ma non ci si azzardi a dire che se la storia è cominciata male, alla fine è andato tutto bene. Non si tratta di commedia, ma di vita vera. Non solo per la Lidia del romanzo, ma per i tanti giovani che hanno subito queste misure coercitive a scopo assistenziale, per il semplice fatto che «il mondo fuori dalla porta pensa che se sei stato punito hai commesso degli errori. Il mondo fuori dalla porta vuole credere che la giustizia, per il nome che porta, sia giusta».
Link: CdT