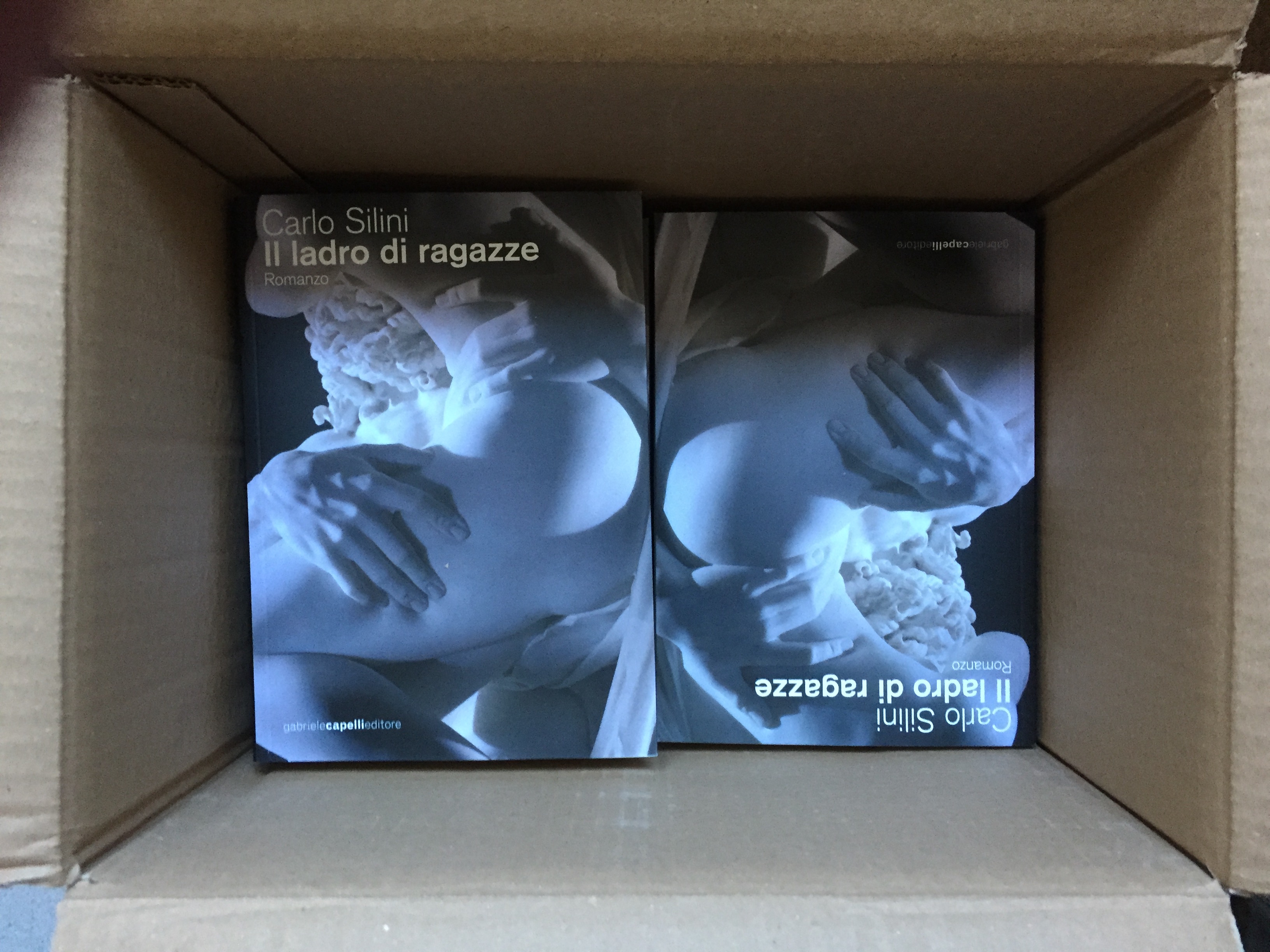Giorgio Genetelli, Merluz Vogn. Di Massimo Frapolli

Giorgio Genetelli, Merluz Vogn
Di Massimo Frapolli, aprile 2020
Ho pensato che fosse beneaugurante prendere in mano questo bel Merluzzo, incartato – nell’iperrealismo dell’immagine – tra la copertina e il suo risvolto come provenisse fresco dal mercato del Borgo, in quest’epoca rabbuiata dall’emergenza sanitaria del coronavirus in cui ha avuto la sorte inopinata di essere pubblicato; ne ho poi avuta conferma percorrendone le pagine e i capitoli: brevissimi, esilaranti e scanzonati flash aneddotici di un’infanzia paesana libera e spensierata, perline colorate su un filo narrativo altrimenti esile che compongono una collana variopinta buona da sgranare a contraltare di questa Quaresima accresciuta, gridando alla vita.
Il protagonista, a cui si adeguano la prospettiva e la voce narrante a tratti sincronica ai fatti, è un bambino di quasi undici anni (“ora che compivo quasi gli undici…” p. 35), possibile alter-ego dell’autore e forse un po’ ritratto dell’artista da giovane in una realtà aumentata dalla fantasia, che narra di un’estate trascorsa nel villaggio nativo in compagnia dei noni, meno assillanti e più indulgenti di genitori che si sono dovuti assentare: il pa’ e la mama, due fantasmi di densa consistenza nell’economia simbolica della narrazione, che nella loro latitanza lasciano intravedere una sorta di trama altra, sotterranea, di una profondità sentimentale o financo psicoanalitica in cui la giocosa leggerezza della superficie si stempera in una vena malinconica alla quale, appoggiando il libro sul comodino dopo aver letto l’ultima pagina, è difficile non cedere.
Gli indizi testuali ancorano le vicende nei secondi anni Sessanta, quando alla radio e nei dischi della Sandra imperversano Celentano e i Beatles, alla TV c’è Corrado con Un’ora per voi e ci si può appassionare alle vicende pugilistiche di Nino Benvenuti, in un paesino nominato soltanto per orgogliosa contrapposizione identitaria ai dirimpettai (Molon, Crei: oggi “cittadini” di “quartieri” di Bellinzona), che è poi il luogo dell’educazione (sentimentale) dell’autore. Rimanere aggrappati alla memoria di quello che era insieme un paese per vecchi e un paese di giovani non è certo, per Genetelli, un’operazione nostalgica, ma diventa quasi un grido d’allarme ideologico, la ricerca spasmodica di un antidoto ad una modernità (e applicabile a questa inattesa attualità, se pensiamo alle norme di “distanziamento sociale” prescritte per il contenimento della pandemia di queste settimane) che disgrega il tessuto sociale intralciando in particolare l’incontro intergenerazionale. Una modernità che l’io narrante osserva arrivare ignaro, tutto assorbito dalle ludiche scorribande e dai racconti del pa’, del nono, del Bianco papà del Nandel (storie di cui è sempre arduo cogliere “il confine tra fantasia e verità” p. 85), e l’autore cristallizza invece in alcuni emblemi del boom economico (basta poco: un giradischi, una piscina); si sarebbe detto, dopo, quasi nunzi di quella globalizzazione alla quale forse è ancora possibile resistere. È forse anche per questo che il tema, solo accennato nel romanzo, della malora e del dramma dell’emigrazione del primo Novecento è introdotto con il ritrovamento di lettere di famigliari della nona in cui fanno capolino, quasi spia intertestuale, i nomi di Gregorio e Maddalena, ad evocare la coscienza critica valmaggese di quel Ticino in transizione, il Martini del Fondo del sacco, presente anche, in controluce, nel tema dell’insofferenza all’ortodossia religiosa di quel mondo rurale, incarnata qui dalla figura monumentale del don Lanzetti; in un moto genuino di anticlericalismo integrale l’autore si può fondere con il narratore e, commentando un sacramento rocambolesco non andato a buon fine, fargli chiosare, tra ieri e oggi: “La bambina non la battezzarono più. E vive benissimo” (p. 38).
Ma forse è un abbaglio del recensore. Sappiamo che la memoria non è mai lineare, e procede piuttosto per reticolati e agglomerazioni: così l’operazione del Genetelli si presenta come un carotaggio nell’humus memoriale (che è un tutt’uno con la naturale mistificazione della finzione creativa) le cui emergenze l’autore si dà licenza di giustapporre e sovrapporre, senza mai però cadere in confusione. Questa memoria solo apparentemente aleatoria del Gene si fa letteratura aggrappandosi a brandelli possibili di geografia e storia strapaesane, che diventano tasselli di un paesaggio interiore, di una cultura della distrazione strategica dove le finestre sull’altrove (gli eroi dello sport, della canzone, della letteratura, dei film e dei fumetti, senza soluzione di continuità) aprono possibilità infinite di lettura dell’esistenza quotidiana (e di interpretazione: quasi uno script e un kit di sopravvivenza) a cui uno non vorrebbe mai rinunciare. E chi mai vorrebbe perdere quello sguardo fanciullesco sul mondo, sguaiato, virginale e dunque salvifico e consolatorio, come un’edenica forza generatrice?
Questa forza è rappresentata al meglio dal compagno d’infanzia più spregiudicato e spericolato (tutti noi ne abbiamo avuto uno), l’incontenibile Nandel, a pieno titolo co-protagonista del romanzo (cui è dedicato il secondo esergo; il primo è per Lindsay e per chi coglie), sparring partner ideale nell’improbabile estate anche perché “sapeva corredare il mondo come nessun altro” (p. 106). Nandel l’incontenibile prova a costruirsi un dispositivo di volo da cui risulta un fallimentare “volo di Icaro” che è, più prosaicamente, un “varèe da merde” (un “volo di merda”, p. 18), infila gavettoni al giro della Svizzera, fino ad organizzare col protagonista una fuga da casa in bicicletta che è un “esodo” alla Thelma&Loiuse, a “divorare lo spazio”, fino al confine del mondo adulto e oltre. Con la stessa irruenza immaginativa, per il protagonista trasportare legna con una carretta troppo pesante, salire ai monti dagli zii o in Cher dal Renato (e tornarne vivi), guadare il fiume o bagnarvisi dopo pranzo senza fare una congestione, sono sfide immani dalle quali ricavare, semmai, come stelle su una divisa, “altre croste di cui vantarsi” (p. 23). Così attraversare il paese dal Pontasel alla Ca’ dal Nandel, o dalla cascata al bosco, è un’epopea memorabile (“La casa dei noni”, che si trova oltre la stalla del Peo, è “come se fosse in un altro continente” p. 9): la mappa del paese disegnata dal protagonista e annessa al romanzo, cosmografia delle sue spedizioni, solo o col Dani e con Nandel, ingigantisce nella percezione infantile il mezzo chilometro quadrato del perimetro municipale rendendolo degno di un’esplorazione come quella della Patagonia; ma c’è di più: con le sue zone off limits, le sue insidie (“sassi vampiri alberi fiumi castelli baratri canyon pareti montagne nevi” p. 105), le sue Terre di mezzo inospitali, le colonne d’Ercole spaventose (Valegion, Bescon, diroccati, raffineria: “Il territorio a sud del paese era quasi inesplorato, ostruito dai torrioni in ferro della raffineria di petrolio e dai possibili veleni che le facevano da fossato” p. 23) la vicenda si colloca in uno spazio anche simbolico per cui sarà appena necessario evocare la grande letteratura d’avventura che solletica l’inconscio infantile e i suoi mostri, da Stevenson, a Tolkien, a Stephen King.
Tutta la narrazione persegue un’epica del quotidiano che passa attraverso la mitizzazione e la sublimazione di personaggi e vicende che hanno il loro più legittimo pantheon “nelle leggende da osteria” (p. 12), sempre sul filo sottile di un’allusività autobiografica; la fotografia – che sarà certo una polaroid – dei personaggi e dei luoghi applica dei filtri che possono amplificare, saturare, distorcere il volto delle cose, sempre lasciando inalterata la “luccicanza” sentimentale degli attori della commedia della vita e del loro palcoscenico locale, che diviene Teatro del Mondo – molti dei quali dall’altissimo tasso di referenzialità (il Renatin, il don Lanzetti, il Mapis; Pasquei, Ca’ dal Geni, la “raffineria di petrolio” Petrolchimica: chi è cresciuto da quelle parti li conosce benissimo, e si divertirà a ri-conoscerli).
Una pietas che trova tanti antecedenti nella letteratura novecentesca, Steinbeck, Fenoglio, Meneghello, fino a De Andrè, per non fare che pochissimi nomi certamente cari al Genetelli, che ne sa impiegare alcuni ferri del mestiere rodati ed imprescindibili, come il ricorso al potere archetipico del mito, antico e moderno, e una ricercata coloritura linguistica, solo apparentemente ingenua e debordante.
Quanto al primo aspetto, la trasfigurazione del quotidiano attraverso il mito classico (acquisito tramite la scuola, le letture) e inglese o americano (nella linfa vitale dei fumetti, della musica) è continua e sbandierata: nell’ascesa ai monti col Nandel convivono, negli orizzonti di gloria dei piccoli protagonisti e nella stessa pagina (p. 53), Kit Carson e gli Achei, la Monument Valley e l’Epoca Minoica; la pervasiva dicotomia indiani-cowboy diventa chiave di lettura del reale nella sua conflittualità ma anche nei suoi risvolti più banali dei giochi fanciulleschi (“nelle epopee del West, siano film o fumetti, non si vedeva mai un eroe o un comprimario andare al cesso. Perché mai dovevano farlo i giocattoli? E poi non avevamo mai costruito un forte che avesse anche il gabinetto” p. 61); se il protagonista gioca a calcio con lo stemma del Liverpool raffazzonato sulla maglietta alla bell’e meglio (p. 23), Pasquei può divenire, come d’incanto, Anfield Road. Ma la menzione, diretta o velata, dei molti prodotti e riferimenti culturali dell’epoca va oltre questa funzione eroicizzante: torna alla mente il romanzo forse più ingiustamente bistrattato di Umberto Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, in cui il protagonista riesce a recuperare la memoria che aveva perduto soltanto tornando alla casa della sua infanzia ed esaminando e ripercorrendo scaffali e scaffali di dischi, libri, fumetti, albi, minuziosamente citati (e riprodotti) nel volume: figurine e depositi di memoria come di identità. Tuttavia, non si pensi che il romanzo del Genetelli abbia le mire di un bildungsroman o di una recherche le cui madeleine siano magari gli amatissimi caffè latte col pane inzuppato, zibak con l’O(vo)maltina, fontina o tilsiter. Ci torneremo in conclusione.
È celebre l’illustrazione di Francesco Guccini al verso fra la via Emilia e il West (che è anche il titolo di un suo disco dal vivo) del brano “Piccola città”, in cui parla della sua Modena, nelle note all’album, in questi termini: “La via Emilia tagliava Modena in due; la strada dove abitavo, da una parte, si incrociava con essa. Dall’altra parte c’erano già gli ampi campi della periferia. Erano un po’ il nostro ‘West’ domestico: bastava fare due passi, o attraversare una strada, e c’erano già indiani e cow-boys, cavalli e frecce; c’era, insomma, l’Avventura, tradotta in ‘padano’ dai film e dai fumetti…”. Sono parole, queste, utili anche a tratteggiare il quadro di riferimento creativo dell’autore del Merluz Vogn, che al verbo gucciniano è devoto e si è lungamente abbeverato. Non gli sarà sfuggito nemmeno il modo in cui l’arguto e colto cantautore emiliano mette al centro del discorso il tema della lingua e della traduzione, che per alcuni anni ha declinato come divertito problema nei suoi concerti con i Nomadi introducendo l’atipico blues in italiano “Statale 17”: “Gli americani ci fregano con la lingua!” – apostrofava Guccini immaginando un’ipotetica trasposizione troppo letterale dell’onomastica di On the road-Sulla strada di Kerouac, in cui tutta la magia sarebbe andata persa – “Quella sera partimmo John, Dean e io sulla vecchia Pontiac del ’55 del babbo di Dean e facemmo tutta una tirata da Omaha a Tucson… e poi lo traduci in italiano e dici: quella sera partimmo sulla vecchia 1100 del babbo di Giuseppe e facemmo tutta una tirata da Piumazzo a Sant’Anna Pelago”.
Sembra proprio muoversi in questo solco Genetelli quando sceglie la lingua, dunque, come nodo cruciale della credibilità del suo Far West addomesticato, come sembra suggerire anche l’ambiziosa quanto criptica formula nella quarta di copertina, che definisce il romanzo come “post-dialettale”, prospettando sicuramente una forma di consapevole sperimentalismo. Certo è che questo romanzo non riduce l’impasto linguistico (italiano, tra impennate liriche e calchi dialettali, dialetto “della ferrovia”, o pan-ticinese, dialetto locale iperconnotato) ad un pur gustoso e apparentemente immediato idioletto mimetico, espressivo o addirittura espressionista, indulgendo piuttosto ad uno studiato divertissement metalinguistico, con cui l’autore si sollazza e intende, ammiccando, gratificare il lettore. Il testo introietta la lingua dei protagonisti, spuria, riportando loro lettere, invettive, racconti, a volte dividendo la pagina in due con la formula editoriale del “testo a fronte”; l’autore predispone poi note al testo a chiarire il significato di alcuni termini dialettali, ma non di tutti né dei più imprendibili, a volte giocando a carte scoperte il gioco del paradosso: gli “intraducibili garof” (p. 29) sono tradotti (“Diroccati”). Se il lettore ha poi la fortuna (come chi scrive qui, per ascendenza materna) di avere quel dialetto locale nell’orecchio, si compiacerà sapendo che marende vale “pranzo”, matelet “ragazzino”, in verdi verdenti “verdenti” è il superlativo, ma anche che Nugru Biuvete, il soprannome di battaglia del Nandel nelle gare con le barchette nel fiume (mentre Merluz Vogn è – finalmente l’abbiamo detto – il nomignolo del protagonista), vale “Nuvola Blu”, ciò che rende quella translitterazione di lingua e di mondi di cui parlava Guccini più perspicua. Ma Genetelli va oltre, puntando sapientemente sulla potenza evocativa dei significanti: il riale che solca il paese diventa “Rii-All” assumendo così, per imperio fonico e analogico, le parvenze roboanti di un tumultuoso Rio Grande nostrano. Da Preonzo al Far West e ritorno, in carrozza come in diligenza.
Si diceva del romanzo di formazione: filone a cui è difficile ascrivere il presente racconto se non per qualche scoria di genere (la mappa richiama una caccia al tesoro, c’è un mistero da scoprire: come scorre la vita nel mondo parallelo della mama e del pa’?) e soprattutto per una spiccata venatura gnoseologica, votata però ad un programmatico nichilismo. “Giovinezza senza vecchiaia, vita senza morte” è l’auspicio che campeggia sul libro che “i signori della raffineria” regalano agli abitanti del paese per Natale, motto che il protagonista legge “senza capire veramente le idee racchiuse dietro alle parole” (p. 61), abbrivio questo ad una perplessità che è anche esistenziale e che perdura fino alla conclusione del romanzo (“Non potevo capire. Chiedere al Nandel sarebbe stato inutile. E non avrei capito nemmeno più avanti…”).
Mi piace immaginare che il Nandel col suo inseparabile amico, il Dani e gli altri, ancora “indaffarati a far niente” (p. 51) e a “sgominare le giornate” (p. 60) o a sfidare l’autorità ponendo “alla postina, al gendarme o al sindaco” quella domanda indiscreta (si veda, con discrezione, p. 81), diventati ormai adulti ma del novero di quegli ostinati che tanto piacciono al Genetelli (che ne aveva fatta la conta in una sua bella raccolta di racconti) vadano piuttosto predicando in qualche osteria di paese il loro credo imperituro, che mi figuro non troppo dissimile da quello ridotto in aforisma dal caustico umorista Gianni Monduzzi: “Odio la maturità: il trionfo dell’ovvio sull’assurdo”.